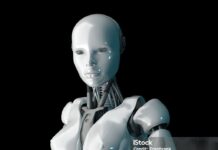Il vangelo di questa domenica ci presente la celebre parabola del ‘figliol prodigo ‘ la quale parla di due modi di allontanarci dall’unico padre. Il primo modo è quello del figlio minore che decide di allontanarsi dalla casa del padre perché non lo sopporta più, vuole farsi una vita autonoma, pensa che lì si soffochi, che non ci sia spazio per la sua realizzazione e per la sua felicità
Il padre della parabola in modo del tutto inaspettato gli dà senza colpo ferire metà dei suoi beni: «e il padre divise tra loro le sostanze (ton bion)» letteralmente «egli divise poi per loro la vita (ton bion)» (Lc 15, 12).
Il figlio minore però una volta partito sperpera tutto e si ritrova da solo a pascolare i porci e ad invidiare le carrube mangiate dai maiali. Nel contesto ebraico, ciò rappresenta quanto di peggio possa accadere ad un uomo: nutrire e far crescere ciò che è considerato immondo, per questo, sintetizza Fausti, «chi si allontana da Dio, fa crescere in sé la sua dissomiglianza da Lui e nutre la propria inidentità con se stesso» (S. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Luca, Bologna 1998, 548.)
La fame e la situazione di miseria in cui si è venuto a trovare lo mettono in movimento: «allora rientrò in se stesso» (Lc 15, 17). Non è ancora la conversione, ma un primo rinsavimento generato dalla fame: «è una conversione a sé più che al Padre»
La fase del ritorno del figlio è particolarmente delicata: occorre vincere quella che Rupnik chiama l’ultima tentazione. Il figlio, infatti, comincia a risvegliarsi e a «rientrare in sé», al pensiero di quanto accadeva nella casa del Padre. Ciò è positivo, è indice di un vero cammino spirituale, ovvero della ripresa – anche se per ora solo nel ricordo e nella nostalgia – del dialogo con il Padre. In questa fase, però, si insinua la tentazione di non entrare veramente in quella relazione dialogica che il peccato ha infranto e di voler risolvere ancora nell’autosufficienza anche la propria conversione.
Il figlio della parabola è infatti tentato, una volta «rientrato in sé», di autopunirsi, mantenendosi in una situazione di schiavitù: «mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni» (Lc 15,18-20). Per questo, dice ancora Rupnik, «l’ultima tentazione cerca di farci rimanere atei, di non farci entrare nella dimensione autenticamente religiosa. Cerca di sostituire la fede come realtà relazionale con una fede intesa come etica, pensiero del bene, come un agire secondo pensieri pii e devoti», mentre invece «credere è amare in una relazione interpersonale agapica, è oggettivarsi nell’altro, cedere il primo posto, rinunciare al protagonismo» (M.I. Rupnik “Gli si gettò al collo”, 42 ss.).
La reazione del padre
Se ora volgiamo la nostra attenzione al Padre notiamo che «quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso (esplanchniste) gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò» (v.20). L’atteggiamento del padre è designato da un’espressione molto forte indicata dal verbo commuoversi (splanchnìzomai), che letteralmente indica il movimento dei visceri, l’attaccamento uterino della madre per il proprio figlio ed è reso nella traduzione CEI con il verbo «commuoversi». Per questo, «la commozione è l’aspetto materno della paternità di Dio: il suo è un amore uterino e necessario, che lo rende vulnerabile e sempre disponibile. La commozione è l’esatto contrario dell’impassibilità o durezza di cuore: è la qualità fondamentale di quel Dio che è misericordia (cf. Lc 6,36). Tutte le Scritture, la legge di Mosè, i profeti e i salmi, narrano la sua passione per l’uomo (Lc 24,26 ss. 44ss.)» (S.Fausti, op. cit, 550). In Dio c’è solo spazio per la misericordia, come si vede dal Libro di Giona o come nelle seguenti espressioni: «mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto» (Sl 27,10); «si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai» (Is 49,15).
Il figlio maggiore
Vediamo ora più da vicino il discorso che fa il padre al figlio maggiore per motivargli la necessità della festa: «perché questo mio figlio era morto (necròs) ed è tornato in vita, perduto ed è stato ritrovato» (Lc 15,24.32).
Nel dialogo con il figlio maggiore ritorna il termine “morto” per descrivere la situazione del figlio allontanato: cosa significa? Un primo aspetto della rivelazione biblica è che essa ci invita a chiamare le cose con il proprio nome e fa conoscere all’uomo ciò che – pur vivendolo – non riesce a vedere. Nell’abbraccio del Padre è possibile riconoscere la situazione in cui ci si è trovati lontani da Lui, così come senza di lui tale analisi condurrebbe inevitabilmente alla tristezza e disperazione.
Il figlio maggiore però è ancora molto arrabbiato si sente defraudato dal padre che vuole premiare il fratello che ha sperperato tutto: entrerà alla festa?