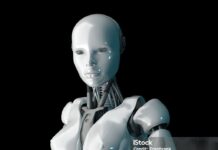Germi evangelici
che spezzano
il muro dell’ignoranza
Osservatore romano del 10 marzo 2025
Storie di chi non si arrende alla guerra in Israele e Palestina
di Marco Tibaldi
Nell’anno giubilare dedicato alla speranza, tutte le realtà che parlano di questa fondamentale virtù teologale vanno diffuse e sostenute. Pensando alla tragedia recente che ha colpito la Palestina e Israele, è una boccata d’ossigeno il libro della giornalista Chiara Zappa, Gli irriducibili della pace. Storie di chi non si arrende alla guerra in Israele e Palestina, con prefazione di Noa (Milano, Ts Edizioni, 2024, pagine 200, euro 19). Il tema scelto per l’anno giubilare impone di «sperare contro ogni speranza» soprattutto in quei contesti, come l’attuale medioriente, in cui i popoli sembrano essere all’interno di un tunnel senza vie d’uscita. Per questo è fondamentale, come ha fatto la giornalista milanese, far conoscere quei germi evangelici che spezzano il muro dell’ignoranza più o meno colpevole, che impedisce di conoscere quelle realtà israeliane e palestinesi che dimostrano nel concreto che la pace e la convivenza dei due popoli è possibile.
Nel libro, vengono riportate dieci esperienze nate in momenti e in contesti differenti, ma tutte unificate dal rendere possibile ciò che per molti è solo un’utopia irrealizzabile: «spesso sono liquidati come folli, ingenui, illusi — afferma Zappa —. Ma l’utopia che inseguono è in realtà la forma più chiara di pragmatismo. Perché è ormai evidente a chiunque che la forza, anche la più soverchiante, non potrà mai garantire incolumità e benessere a nessuna di queste due comunità talmente vicine da essere inseparabili». È proprio questa la sensazione che si ha leggendo le pagine del testo. Appare infatti sempre più evidente la stupidità del male che, pur avendo forse delle motivazioni, non riesce mai a raggiungere gli scopi che si prefigge.
È questa, tra molte, l’esperienza di un ufficiale dell’esercito israeliano Chen Alon che, pur avendo partecipato a molte operazioni militari in Cisgiordania e Gaza, a un certo punto dopo la nascita della figlia, ha capito l’assurdità della risposta militare al conflitto con i palestinesi e ha deciso di aderire, come altri suoi commilitoni, al movimento Courage to refuse («il coraggio di rifiutarsi»): «Non riuscivo più a guardare ai bambini palestinesi come “piccoli terroristi” o ragazzini destinati a diventarlo, un giorno. Tenendo in braccio mia figlia, non potevo più mentire a me stesso e negare che anche quei giovanissimi palestinesi fossero esseri umani, per i quali i genitori si preoccupavano esattamente come io mi preoccupavo per la mia bimba».
La riconciliazione e il perdono in questi contesti sono molto difficili, ma non impossibili, come dimostra l’esperienza di Layla, una donna palestinese del villaggio di Battir nei territori occupati nei pressi di Betlemme a cui è morto un figlio a causa dell’insipienza dei soldati israeliani, che le impedirono di recarsi all’ospedale fermandola inutilmente a un posto di blocco. Dopo molti anni chiusa nel suo dolore, grazie a un amico, è entrata in contatto, non senza resistenza, con l’organizzazione Parents’ Circle – Families forum, che raccoglie donne palestinesi e israeliane che hanno perso un figlio a causa del conflitto: «Per Layla ascoltare il dramma di chi aveva visto un familiare morire in un attentato suicida, o di chi aveva perso un figlio colpito da un cecchino palestinese fu uno shock». Ma anche l’inizio di una nuova consapevolezza, che le avrebbe cambiato la vita. «Per la prima volta — afferma Layla — mi resi conto che condividiamo lo stesso dolore, le stesse lacrime». Da allora è diventata una convinta attivista del movimento, che non ha cessato le sue attività nonostante il recente conflitto, visto da molti in entrambe le parti, come la conclusione di ogni possibile sogno di riappacificazione. Al contrario per Layla è vero che «sono i governanti ad avere in mano le scelte politiche, solo loro possono firmare un accordo di pace. Ma solo noi, cittadini comuni, abbiamo il potere di fare la riconciliazione».
Le esperienze raccolte da Zappa mettono bene in luce i passi possibili di questo itinerario. Un ruolo fondamentale è giocato dall’educazione, come dimostra l’esperienza dell’anziano professore palestinese Mohammed Dajani Daoudi, il quale dopo aver compiuto gli studi universitari in Libano perfeziona la sua formazione in scienze politiche in America e questa, come lui stesso racconta, «fu un’esperienza fondamentale perché mi permise di muovere i primi passi fuori della caverna dell’ignoranza e dell’estremismo, e di assumere una nuova prospettiva».
Anche lui ha cominciato attraverso la conoscenza di ebrei americani a capire le posizioni dell’altro del “nemico” e a collocarsi in quella che, nella spiritualità coranica, è la virtù della moderazione la wasatia. Decisivo fu per lui un viaggio, come direttore dell’Istituto di studi americani alla Al Quds University, ai campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau, a cui accedevano per la prima volta studenti palestinesi. Per alcuni di loro fu un vero e proprio shock, vista la rimozione storica della Shoah nel contesto palestinese; per tutti fu però quella l’occasione per comprendere le differenze storiche tra la persecuzione nazista e le violenze subite nel dopoguerra dal popolo palestinese e sopratutto per focalizzare che «se per il popolo ebraico ovviamente non ci fu alcun margine di trattativa con i nazisti, nel caso del conflitto israelo-palestinese i negoziati e la riconciliazione rappresentano l’unica opzione, che oggi è congelata perché il controllo, da entrambe le parti è in mano agli estremisti. mano agli estremisti».