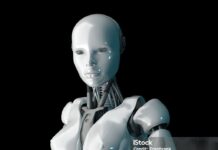L’Antico Testamento
e la sete di capire

Osservatore Romano del 12 aprile 2025, p.7
di Marco Tibaldi
La Quaresima è un tempo di purificazione della vita del cristiano, per far sì che si possa gustare a pieno la forza e la bellezza delle celebrazioni pasquali. Tra i vari aspetti bisognosi di continua sorveglianza si trova l’immagine o le immagini di Dio che ciascuno porta in sé. Uno dei temi che maggiormente interroga sia il credente sia il non credente è quello relativo alla bontà di Dio. Basta vedere un telegiornale per entrare in crisi, per non parlare delle situazioni personali che ciascuno vive. Come mai Dio non interviene? Perché permette che avvengano tante malvagità spesso compiute proprio in suo nome? Uno degli antidoti più potenti che abbiamo a disposizione per contrastare i dubbi e la tristezza o la rabbia che suscitano i suddetti interrogativi è il ricorso alla Parola ispirata, che come «lampada sul mio cammino» (Sl 119, 105) ci viene in aiuto. È sorprendente notare, come è già stato fatto anche dal nostro giornale, come il recente successo del fortunatissimo Il Dio dei nostri padri del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo segnali il desiderio più o meno consapevole di ricevere dalla Bibbia luci sul rapporto tra Dio e la storia degli uomini, entro cui si inscrive anche la storia personale di ciascuno. Il testo del celebre giornalista ripercorre per sommi capi le tappe principali delle vicende dell’Antico Testamento, dalla creazione fino alle soglie del Nuovo. Pregevole è l’iniziativa di voler riavvicinare il vasto pubblico alla conoscenza della Bibbia, la grande assente nella formazione culturale del nostro paese. Fin dalle prime pagine, viene ribadito il superamento di una delle resistenze culturali che hanno segnato la polemica degli ultimi secoli, da Galileo in poi, tra fede e scienza: «Ma come il mondo sia nato, come l’energia sia diventata materia, questo non si sa. L’attimo la scienza non l’ha colto, e forse non lo coglierà mai. E se non sappiamo il come, figurarsi se sapremo mai il perché» Con queste espressioni Cazzullo non sancisce la vittoria di uno dei due contendenti sull’altro, quanto piuttosto la reciproca distinzione e complementarietà di interpretazione dei medesimi fenomeni, come già Galileo a suo tempo aveva intuito. Non è necessario essere atei per essere buoni scienziati, così come non è necessario tirare in ballo Dio, per colmare le lacune della conoscenza umana (D. Bonhoeffer). Ciò che però non è ancora giunto a maturazione, come si evince dalla lettura del testo di Cazzullo, è la mancata presa di consapevolezza della necessità di integrare la lettura del testo sacro con una presentazione, anche minimale, dei diversi generi letterari che sono utilizzati nel testo e, sopratutto, del ruolo fondamentale che hanno avuto nella redazione del testo gli scrittori umani, quelli che la tradizione identifica come agiografi. Non si tratta di trasformare un invito alla lettura in un complesso e pedante manuale di esegesi, quanto aiutare il lettore a cogliere alcune dinamiche profonde del testo biblico che, se non rettamente comprese, rischiano di fuorviare completamente l’interpretazione. Come già avvertiva san Paolo, una lettura eccessivamente letterale del testo (2Cor 3,6) ne uccide il senso e spesso purtroppo non solo quello. Per questo qual è il rischio che corre un lettore non avvertito sul ruolo del redattore nella Scrittura del testo ispirato leggendo passi e commenti come il seguente? «Le piaghe d’Egitto rappresentano il sovvertimento della creazione. Dio colpisce prima attraverso l’acqua, mutata in sangue, poi attraverso l’aria, infestata di insetti, quindi attraverso la terra, con la strage del bestiame; e alla fine dovrà colpire direttamente l’uomo».
Non è forse indotto a pensare che Dio, quando decide di agire in modo spietato lo fa senza ritegno, come nel caso dell’ultima piaga d’Egitto, colpendo direttamente i primogeniti del faraone e degli egiziani? Ma un Dio che colpisce gli innocenti non è forse un assassino? E come si fa ad avere fiducia in un Dio siffatto? La necessità, che dal Vaticano ii è stata ribadita più volte, di conoscere quali sono le intenzioni del redattore biblico e del ruolo che gioca la pedagogia divina nel lasciarsi capire in modo parziale e spesso equivoco dagli uomini, è indispensabile per far capire il retto modo di intendere quei passi davanti a cui si trova il lettore dell’Antico Testamento dal diluvio, all’esodo alla conquista militare della terra promessa.
Da ultimo per chi è cristiano è questa la lettura proposta da Gesù che ricorda ai lettori di tutte le epoche, che lui è il volto del Padre (Gv 14,9), il suo esegeta (Gv 1,18) e che ogni volta che leggendo i passi difficili dell’Antico Testamento, in cui il redattore attribuisce a Dio i sentimenti che sono solo suoi, è a Lui che dobbiamo guardare. Così facendo, si potrà scoprire che il Padre non ha mai voluto la morte di nessuno, né dei malvagi né tanto meno degli innocenti. In questo modo, potremo riscoprire e gustare tutta la ricchezza che c’è nel cammino di scoperta del volto di Dio testimoniato nell’Antico Testamento e ridare a Dio quell’onore che gli spetta.