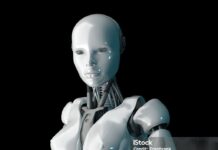Il Novecento ci ha mostrato, spesso in modo tragico, che le innovazioni scientifiche o tecnologiche non sono mai neutre. Dalla scoperta della dinamite all’energia atomica è un’illusione ritenere che le nuove scoperte si autoregolino nel loro utilizzo. La riflessione etica è ineludibile per valutare l’impatto che le nuove tecnologie hanno sulla vita sociale. Questo è particolarmente vero per tutto ciò che riguarda le acquisizioni del mondo digitale con il tema dell’intelligenza artificiale in testa. In questo settore l’illusione che le cose si possano sistemare da sole è ancora più forte che per altre tecnologie. Ciò è dovuto in parte agli innumerevoli benefici che le tecnologie digitali hanno portato ad un numero illimitato di persone – chi ormai non possiede almeno un telefonino? – e sia alla velocità ed efficacia con cui tali tecnologie si diffondono. Eppure non bisogna cadere nel tranello. Di questo di occupa l’ultimo ottimo e documentato testo di Luciano Floridi, professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione all’università di Oxford e di Sociologia della cultura e della comunicazione nell’università di Bologna, Etica dell’intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide, Raffaello Cortina Editore, Milano 2022, pp. 384 € 26.
La pervasività delle
nuove tecnologie è particolarmente evidente poiché: «Istruzione,
affari e industria, viaggi e logistica, banche, vendita al dettaglio
e shopping, intrattenimento, welfare e sanità, politica e relazioni
sociali, in breve la vita stessa per come la conosciamo oggi è
diventata inconcepibile senza la presenza di pratiche, prodotti,
servizi e tecnologie digitali. Chiunque non sia stupito di fronte a
tale rivoluzione digitale non ne ha afferrato la portata».
Per comprendere tutto questo, occorre conoscere come funziona questo
mondo, che sta sempre più modellando le nostre esistenze private e
pubbliche. Il testo di Floridi si configura come un manuale completo
di tutte le questioni etiche che sono coinvolte nello sviluppo delle
nuove innovazioni tecnologiche.
La prima cosa da capire è che il
digitale sta operando una trasformazione radicale del nostro modo di
concepire la realtà, al punto che Floridi parla di
«re-ontologizzazione»,
perché realtà come «le
nanotecnologie e le biotecnologie stanno non semplicemente
re-ingegnerizzando il mondo ma lo stanno ridefinendo»,
modificando profondamente visioni e modelli che hanno tenuto banco
per secoli.
Il digitale poi offre inedite possibilità di
reinvenzione della realtà, per cui l’attività innovativa che
definisce la nostra epoca è il design, anche se, ricorda
Floridi, «naturalmente
ogni design richiede un progetto. E, nel nostro caso, si
tratta di un progetto umano per la nostra epoca che ancora ci manca».
Per mettersi su questa strada, occorre capire che l’intelligenza
artificiale, che è il cuore delle innovazioni di cui stiamo
parlando, si fonda su un «divorzio»
ben riuscito tra «l’agire
e l’ intelligenza»,
perché l’ IA è la «capacità
di agire interattiva, autonoma e spesso autoapprendente che può
affrontare un numero sempre più elevato di problemi e attività che
richiederebbero altrimenti l’intelligenza e l’intervento umani».
Questa definizione chiarisce un equivoco diffuso a livello popolare
da tanta letteratura e cinematografia, che l’IA sia una vera
intelligenza umana. Ciò però non vuol dire che le possibilità che
offre non debbano essere vagliate eticamente dalla coscienza. Su
questo aspetto, Floridi mette in guardia dalla confusione che si è
venuta a creare a causa della proliferazione dei criteri etici,
spesso moltiplicati ad arte per lasciare, al modo del Gattopardo, che
tutto cambi perché nulla cambi di fatto, o perché ciascuno si
scelga a piacimento i principi che più gli fanno comodo. In questa
linea, troviamo anche i rischi, denunciati da Floridi, del
Bluewashing etico, che consiste nel mostrarsi più etici dal
punto di vista digitale di quanto non lo si è effettivamente. Lo
stesso effetto distorcente, avviene per il Lobbismo etico, che
consiste nell’ostacolare l’introduzione di norme etiche specifiche
per il digitale o il Dumping etico che consiste nell’esportare
in altri contesti o paesi procedure digitali considerate
inaccettabili, ad esempio all’interno della UE, per finire con
l’elusione etica che consiste nello scarso impegno nell’affrontare le
questioni etiche, visto il basso ritorno che possono offrire.
In
positivo, si tratta di mappare e orientare eticamente il variegato
mondo degli algoritmi, ovvero quei costrutti matematici che
presiedono al funzionamento dei dispositivi digitali. Si è già
messo in luce che molti di questi agiscono in modo da far aumentare i
pregiudizi o le discriminazioni sessuali o sociali. Per contro se
bene orientati, essi possono essere un fattore di promozione civile
e progresso, ad esempio nel livellare le disuguaglianze culturali o
per implementare la transazione ecologica.
Se l’algoritmo è ben orientato – L’Osservatore Romano del 18 08 2022